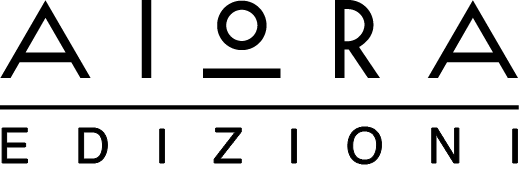Il loggione
Recensione di Elisabetta Garieri – Argo magazine
https://www.argonline.it/il-loggione-di-ghiannis-ritsos/
Nell’anniversario della nascita di Ghiannis Ritsos, una panoramica sulla vita e le opere del poeta greco, a partire dalla raccolta “Il loggione” (Aiora 2018).
di Elisabetta Garieri
Aiora – in greco αιώρα, «amaca» – è una casa editrice indipendente con sede ad Atene, nel quartiere di Exarchia, storico luogo dell’editoria greca. Nata nel 1997, è attivamente impegnata nella promozione della cultura letteraria greca presso i lettori stranieri, con collane in lingua inglese, francese, italiana e spagnola. Nel 2018 ha pubblicato Il loggione di Ghiannis Ritsos, nono titolo della collana «Classici greci moderni», che offre al pubblico italiano una delle raccolte inedite, lasciate dal poeta dopo la morte. Traduzione e introduzione sono di Maria Caracausi, docente di neogreco all’università di Palermo.
Saponata, fango, erbacce,
muri segnati –
quanti giustiziati.
I bottoni delle loro giacche,
delle loro camicie,
accumulati
in una scatola di ferro,
risuonano di notte.
Cucio, scucio versi
per abbottonarli fino al collo
che non mi si raffreddino,
che non si dimentichino di me,
che insieme non mi dimentichi anch’io.
(Rievocazione, Atene, 15.III.85)
*
Nel quartetto di poeti greci moderni noti al pubblico europeo, al di fuori della cerchia degli specialisti, ampia è la fama dell’alessandrino Costandinos Kavafis, mentre Ghiorgos Seferis e Odisseas Elitis sono conosciuti anche grazie al premio Nobel per la letteratura, ottenuto da entrambi, rispettivamente nel 1963 e nel 1979. Ghiannis Ritsos invece (Monenvasià 1909 –Atene 1990), è quello che forse, almeno in Italia e per le nuove generazioni, rimane più in ombra, nonostante la sua sia una delle grandi voci della poesia europea del ‘900. Diversa la situazione in Francia, dove la poesia di Ritsos arrivò veicolata da Louis Aragon, e si trovò così ad avere, fin da subito, un pubblico di riferimento.
Cresciuto in una famiglia della vecchia nobiltà, che finì però sul lastrico, iniziò giovane a scrivere poesie e a dipingere. Era un artista a tutto tondo, e quando si trasferì ad Atene fece i mestieri più vari: attore, ballerino, correttore di bozze, giornalista, traduttore. Dopo aver perso la madre e il fratello maggiore a causa della tubercolosi, si ammalò lui stesso. Come altri autori del Novecento (Paul Éluard, per esempio) in sanatorio conobbe il marxismo e si politicizzò; lì condusse anche le prime battaglie, contro le pessime condizioni delle strutture che ospitavano lui e gli altri malati.
Nella vita subì diverse forme di internamento, imposte a lui e ai suoi cari: il sanatorio, l’ospedale psichiatrico (dove finirono la sorella e il padre), e poi i campi di prigionia nelle isole dell’Egeo, dove fu incarcerato a più riprese in quanto resistente, contro l’occupazione tedesca prima e il regime dei Colonnelli poi. Per molto tempo, i suoi libri furono oggetto di censura.
Affrontò sempre la prigionia come una sofferenza collettiva e non individuale, con la consapevolezza profonda che o ci si salva insieme, o non si salverà nessuno. Altrettanto profonda era la sua fiducia nella possibilità di riscatto offerta dalla fratellanza tra gli uomini, e dal desiderio di giustizia e uguaglianza. Conscio che nessuna repressione avrebbe mai potuto soffocare quelle spinte, traspose la sua fiducia in poesia, esigenza umana vitale, per lui, tanto più in condizioni inumane. Se, sotto tortura, non ritrattò mai le sue opinioni, rifiutò poi di erigersi singolarmente a eroe:
Non state a dire che ho fatto qualcosa di importante
sono solo passato e mi sono appoggiato allo stesso muro dove
vi siete appoggiati voi
miei compagni
scrisse, ne Il paiolo annerito1. Proprio per questo, forse, il continuo misurarsi con gli eroi della mitologia antica è tanto centrale nella sua poetica, anche negli scritti dei periodi di reclusione, come sintetizzano i fulminanti versi di Eracle e noi «[…] Quanto a noialtri, figli di mortali […] / Non ci sentiamo affatto inferiori […] / E se maldestri / dovessero sembrarvi un giorno i nostri versi, ricordate / solo che furono scritti / sotto il naso delle guardie, la baionetta puntata sempre / alle costole./ Né servono giustificazioni – prendeteli nudi come sono, – / l’austero Tucidide vi dirà più del raffinato Senofonte»2.
I lettori italiani conoscono la poesia di Ritsos in buona parte grazie alle pubblicazioni dell’editore e traduttore Nicola Crocetti, che di lui fu anche amico stretto; e a sporadiche pubblicazioni di altri editori: niente in confronto alla sua produzione poetica, a dir poco sterminata.
Per Ritsos la poesia era di importanza vitale: scriveva ogni giorno per ore, al ritmo di tre o quattro nuove raccolte all’anno; troppe per pubblicarle tutte mentre era in vita. La sua opera omnia consta di quattordici volumi, pubblicati in Grecia dalle edizioni Kedros, ai quali si aggiungono cinquanta raccolte inedite, da lui lasciate dopo la morte.
Come ricorda Maria Caracausi nell’introduzione a Il loggione3, è difficile riassumere i temi di questa produzione imponente, ma di certo quella di Ritsos è «una poesia politica nel senso più alto del termine», perché chiama i lettori a «interrogarsi su se stessi per trovare – in se stessi – le risposte». Questo accade sia quando al centro della riflessione poetica c’è il mito, come in Quarta dimensione4, «uno dei libri capitali della poesia di ogni tempo»5, dove il poeta mette in bocca a Elena, nel monologo omonimo, queste parole: «Ah, sì, quante battaglie, eroismi, ambizioni, superbie / senza senso, / sacrifici e sconfitte e sconfitte, e altre battaglie, per cose / che erano state già decise da altri in nostra assenza. […] / Eppure – chissà – / là dove qualcuno resiste senza speranza, è forse là che / inizia / la storia umana, come la chiamiamo, e la bellezza / dell’uomo / tra ferri arrugginiti e ossi di tori e di cavalli, / tra antichissimi tripodi su cui arde ancora un po’ / d’alloro / e il fumo sale nel tramonto sfilacciandosi come un vel- / lo d’oro»; sia quando la poesia muove dalla sofferenza di una vita costellata dai lutti familiari; sia quando a dettare i versi sono le circostanze di oppressione, durante le dittature e nei reiterati periodi di prigionia, come in Pietre, Ripetizioni, Sbarre6; sia quando la poesia diventa un inno, in diretto riferimento all’attualità politica, come in Epitaffio7 e Grecità8, entrambe trasposte in musica da Mikis Theodorakis. Dagli anni ’60 del Novecento in Grecia la musica svolge una funzione «in parte ancillare»9 rispetto alla poesia, situazione quasi unica in Europa, e i versi di Grecità cantati da Theodorakis sono popolarissimi: «Questi alberi non sono a loro agio sotto poco cielo / queste pietre non sono a loro agio sotto il piede straniero, / questi visi non sono a loro agio che al sole, / questi cuori non sono a loro agio che nella giustizia»10.
Tra le cinquanta raccolte inedite – finché il poeta era in vita – si inserisce Hyperoon (Il loggione), silloge di quarantacinque componimenti brevi scritti nel 1985, in meno di un mese, ad Atene, e pubblicata per la prima volta da Kedros nel 2013.
I componimenti de Il loggione appartengono al filone delle poesie brevi scritte da Ritsos dopo la guerra. Si tratta di versi che scaturiscono da piccole situazioni quotidiane, all’apparenza insignificanti e lontane dalle grandi questioni – eroismo, memoria, storia – sollevate dall’altro filone sviluppato dall’autore in quel periodo: i monologhi lunghi poi confluiti in Quarta Dimensione.
Le poesie brevi de Il loggione aprono uno spazio più intimo, più sommesso, che sembra rispondere ai versi de Il paiolo annerito11, dove il fragore dei grandi discorsi pieni di orgoglio viene descritto come un modo per nascondere insicurezza e paura: «A volte siamo pieni di orgoglio, fratello / perché non ci sentiamo affatto sicuri. / Dicevamo grandi parole / mettevamo molti galloni d’oro al braccio del nostro canto / […] facevamo chiasso – avevamo paura, perciò facevamo chiasso».
Qui il poeta è discreto, non declama da un palco («Allora pronunciavamo discorsi dalle tribune di legno, dai / balconi, / strillavano le radio, ripetevano i discorsi, / dietro alle bandiere si celava la paura» ricorda ancora ne Il paiolo annerito) ma guarda il mondo dall’hyperoon, il loggione del teatro o del cinema – anticamente, anche quello usato come gineceo in case e chiese. In un articolo sulla rivista online Àtechnos, Ireneos Marakis ricorda come chi sta nel loggione resti nascosto agli sguardi dei più, pur essendo tanto vicino alla gente; e come questa sia una metafora della postura del poeta, «ben saldato al corpo sociale», ma «lontano dagli sguardi indiscreti», che l’autore dell’articolo ipotizza siano quelli delle autorità, responsabili della repressione. Eppure nella poesia che dà il nome alla raccolta, Nel loggione, il poeta è rimasto solo nel teatro vuoto: «[…] Tocca a te ora, / senza luci, / senza scene e spettatori, / recitare te stesso».
Ne Il loggione le parole fanno capolino nel mondo, di tanto in tanto, furtive, come se chi le pronunciasse stesse rubando qualcosa alla realtà quotidiana: il diamante grezzo delle ultime strofe di Nelle miniere di carbone, per esempio: «Io / mi ero nascosto in grembo il grosso diamante / grezzo. / Salii sul vagone. Il conducente mi guardò, / mi strizzò l’occhio destro e partimmo».
Come chi si trova nel loggione, il poeta osserva la realtà senza essere osservato, e ne carpisce dettagli, marginali a uno sguardo sommario, essenziali al suo: «La polvere sul fondo del tramonto / ha preso la forma di un Angelo. Io, inosservato, / ho spiumato un’ala dell’Angelo / e vi scrivo lieto la mia pena.», recita la chiusa di Dalle retrovie. Il poeta si aggira solo con le sue parole, attento a non farsi notare, avvertendo la morsa del controllo pronta a chiudersi su di lui. Sono gli anni Ottanta e la dittatura è finita, ma l’impronta lasciata dalla vita clandestina e dalle persecuzioni è indelebile, come testimoniano la chiusa e il titolo stesso di Precauzione: «Io solo / con la parola Dogana Terminale / con la parola Termo, / con la parola Termine. / Se accendo una sigaretta / mi vedranno». Andare in cerca di quelle scorie della realtà che ne costituiscono la vitalità: «Dietro il muro di cinta, / occhiali spezzati / brocche spezzate e lattine vuote, / i cani afflitti, i gatti selvaggi, / una quantità di ortiche, e in mezzo a loro / un piccolo fiore giallo, / come una stella trascurata,/ si è assunto l’onere di pagare / per tutti i cocci. / E insieme anch’io» recita Discarica; raccogliere i cocci di tutto ciò che sfugge a occhi puntati solo su ciò che, si dice, conti, come in Accumulo: «Uomo strano: raccoglie / chiodi arrugginiti, / lampadine fuse, / rocchetti vuoti. / Forse questa inutilità / gli dà una qualche utilità / perché / quando apre la finestra / la prima nuvola è sua amica, / la seconda collega, / la terza stella è la sua matita / per scrivere e cancellare / i segreti del mondo». È questa la tensione del poeta ne Il loggione.
È il periodo della metapolìtefsi – la transizione democratica che segue la fine della dittatura dei Colonnelli del 1974 – e Ritsos non è più in prima linea nelle battaglie per la libertà, ma il suo occhio attento è testimone di una realtà che non si rivela poi così pacificata. È tempo di Mutazione
Molte cose sono difficili, ancora più difficili –
i fagotti dei profughi sul marciapiedi,
la cartoleria chiusa,
le stampelle dell’edicolante,
un uccello marino, una stella, un albero di nave.
Molte cose si rivoltano al tuo sguardo,
molte cose diffidano del tuo tocco.
E devi di nuovo vegliare
fino a quella commossa apatia finché, al termine,
nulla sarà più in disaccordo con te. Sali,
c’è un posto in autobus. Piove.
Dai recessi di una quotidianità velata di malinconia, che sa tanto di day after, la fiducia nel ruolo della poesia resta immutata; e chiama a raccolta tutte le sue risorse per ricostruire un mondo che ha tanto bisogno di poeti quanto di minatori, zingari e stranieri, Artemidi, civette e sordomuti.